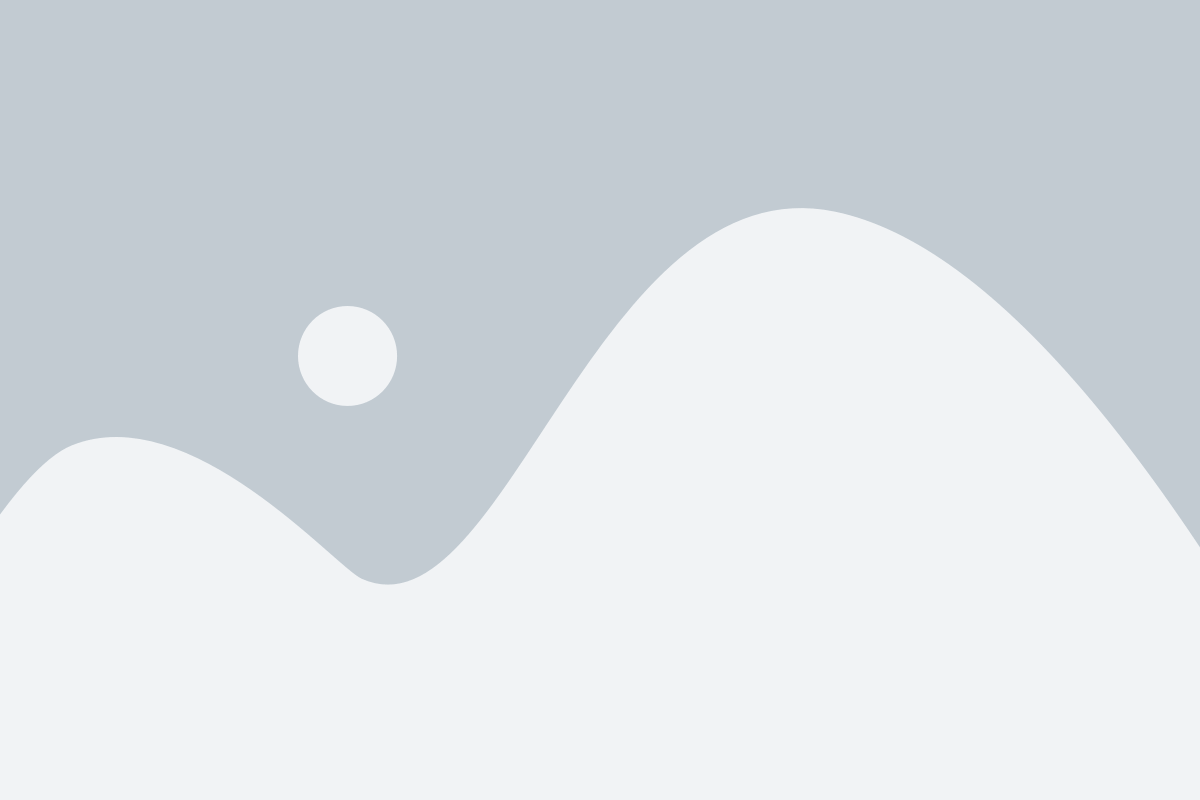Storia della sarda a beccafico
Dai piani nobili ai vicoli di Palermo
Nel settecento a Palermo era uso per l’aristocrazia mangiare un piccolo uccelletto meglio conosciuto come beccafico. Chi cucinava questa ed altre delizie per i nobili era il monsù, il cuoco generalmente francese che sarebbe stato più appropriato chiamare monsieur le chef.
Ma i palermitani hanno sempre avuto poca dimestichezza con le lingue straniere, quindi il nome corretto fu abbreviato in monsù. Era lui che impiattava l’uccelletto ponendone, in modo decorativo, la coda all’insù e suscitando la curiosità dei servitori che rimanevano esterrefatti da tanta inventiva e abilità. Ciò li spingeva, tornando a casa dalle loro famiglie, a riproporre la stessa ricetta ma con ingredienti più economici giacché il beccafico era troppo costoso.
L’alternativa fu trovata nella sarda, un pesce che risultava ancora più economico quando, invenduto da qualche giorno, aveva perso freschezza e qualità. Aperta e deliscata, fu utilizzata come base per un involtino il cui ripieno era semplice pan grattato tostato a cui si aggiungevano sale, acciughe spezzettate, uva passa e pinoli. L’involtino così composto veniva sistemato in una pirofila con aggiunta di foglie di alloro e succo di agrumi (limone o arancia) e con la coda all’insù in ricordo della ricetta da cui traeva origine.

Nulla era lasciato al caso; pinoli e alloro avevano lo scopo di evitare intossicazioni alimentari dovute al pesce non più fresco. Il cibo nutriva ma in se conteneva anche il rimedio medico che lo rendesse assimilabile.
Oggi nessuno cucina più la capinera mentre la sarda a beccafico è diventata un must della cucina siciliana. Nel corso degli anni la cucina dei gattopardi è andata scivolando dalle ricche tavole dei piani nobili fin giù per le strade, dove è stata reinterpretata dalla gente più umile sopravvivendo a quella della nobiltà.